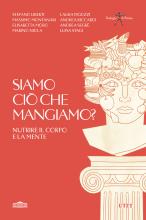Non è la prima volta che mi trovo a esprimere la mia gratitudine e la mia vicinanza, la mia amicizia, quasi una mia parentela spirituale e sentimentale con Pistoia e gli amici pistoiesi; amici nel senso forte, gaio, quello che in triestino si dice “essere una ganga”. Abbiamo anche tanto riso insieme, bighellonando per le incantevoli vie e piazze di Pistoia, e non è poco, se si pensa a quanto rare - e forse sempre meno - occasioni di armonia e di piccola felicità abbiamo nello scorrere dei nostri giorni.
Pistoia fa parte della storia della mia famiglia, perché allo scoppio della Prima Guerra Mondiale – suicidio d’Europa e inutile strage, come la definì il Papa di allora, Benedetto XV – mio nonno Sebastiano, che si era trasferito da Malnisio, in Friuli, a Trieste che allora faceva parte dell’Impero absburgico, aveva voluto conservare la cittadinanza italiana e quando era arrivata la guerra aveva dovuto andarsene e si era trasferito, con la famiglia, a Pistoia, dove aveva trovato un lavoro. Mio padre mi raccontava spesso della Pistoia della sua adolescenza, dei costumi della città (che comprendevano, cosa che mi sconcertava, pure feroci lotte di cani, organizzate illegalmente). Mi raccontava dei suoi amici, della loro ospitalità e delle loro scorribande, dei compagni di classe e degli insegnanti del loro Liceo – in particolare, se non ricordo male, di un professore di storia, Tempestini, il quale sosteneva di essere l’unico a sapere cosa si erano veramente detti Vittorio Emanuele II e Garibaldi nel famoso incontro di Teano, ma non diceva mai cosa si erano detti. In un incontro di qualche anno fa gli amici pistoiesi mi hanno fatto un regalo particolarmente importante, una copia delle onorevoli pagelle di mio padre al Liceo pistoiese. Un capitolo della mia storia famigliare.
Discorsi sull’uomo. Anzitutto chi è veramente autorizzato a tenerli, chi ha le carte in regola per tenerli, questi discorsi? Il fatto di appartenere alla categoria di cui si parla, agli uomini, di essere un uomo che ritrae o magari celebra l’uomo, è garanzia di verità e autenticità, testimonianza di chi parla con cognizione di causa di ciò che si suppone sappia ossia di se stesso, oppure nulla può essere ingannevole come parlare di se stessi? Nel suo capolavoro De hominis dignitate Pico della Mirandola, principe degli umanisti vissuto a Firenze alla corte di Lorenzo de’ Medici, considera anche suo quel privilegio dell’uomo che egli proclama - il privilegio, egli dice, di essere l’unico essere libero nell’universo.. Siamo sicuri di conoscere tutto l’universo per poter affermare, attribuirci questo primato? Mai come ora, del resto, la civiltà, la cultura, la società pretendono di erigersi al di sopra dell’uomo e di subordinarlo a sé.
Non a caso, nel corso dei millenni, sono state attribuite all’uomo, quali suo i contrassegni, la nobiltà d’animo e la bassezza più sordida; nel mondo classico eroi diventano déi, nel cristianesimo Dio esplica la propria pienezza diventando uomo.
Se volessi e potessi, assurdamente, inviare in remotissimi spazi, distanti miliardi dii anni luce, una pagina che potesse far capire ad eventuali inimmaginabili esseri qualcosa dell’uomo - chi siamo, dove andiamo e vorremmo andare - non avrei dubbi. Invierei il Coro che nell’Antigone di Sofocle inizia con i versi “che cosa non è l’uomo!”.
Ci sono certo altre pagine non meno, anzi forse più grandi – Dante, Shakespeare, Omero, Kafka, Dostoevskij e altri, ma forse nessuna come quella ha espresso la terribile alterità dell’uomo rispetto a tutte le altre forme e realtà della vita. Nel coro sofocleo l’uomo è “una meraviglia da far paura”. Certamente tutte le specie viventi si evolvono, cambiano, diventano altre; le piante, gli animali, le. aggregazioni di cui sono fatte le cose minime e invisibili. Un processo, una realtà universale che forse nessuno ha rappresentato come Lucrezio nel De Rerum Natura. Ma perfino nel poema di Lucrezio, in cui la natura delle cose opera nella crescita delle messi come nel fragore dei cataclismi e nella creazione di capolavori della poesia, l’uomo sembra avere una particolare natura auto- trasformatrice e distruttrice, un elemento di sovversione radicale, in ogni campo; dopo l’eruzione del vulcano Uomo la Terra non è stata più la stessa.
Ma nel Coro di Sofocle questo processo si accelera, si scatena, irrompe a sconvolgere leggi, valori e sentimenti che la comunità umana vive come durature, stabili leggi del mondo della mente e del cuore. L’uomo disseziona, altera, annienta i fondamenti stessi della stabilità e della continuità del suo essere. La Grecia tragica dice sull’uomo cose che sentiamo più vicine delle lodi e dell’ammirazione dell’uomo espresse dalle civiltà umanistiche, che ne esaltano un valore perenne.
Anche spiriti pessimisti e turbati dalla visione del mondo, dagli spazi infiniti e dalla “miseria” dell’uomo come Pascal, trovano nel pensiero e nella coscienza una grandezza. Nel grandioso pessimismo con cui Leopardi guarda le vaghe stelle dell’Orsa c’è un’universalità dolorosa ma oggettiva. La differenza – non solo, ovviamente, di valore poetico – fra Pico della Mirandola e Leopardi è enorme, ma è ancora più grande quella tra le opere anche più pessimiste e negative e lo stasimo di Sofocle, in cui l’uomo è materiale incandescente che può, anzi è condannato a cambiare se stesso e il mondo che lo circonda, a diventare veramente “altro” per i suoi simili, rapidamente avviati a diventare suoi ex-simili, alieni e diversi come lo è un robot o un cyborg dagli uomini che hanno dipinto le grotte di Altamura, scritto la Commedia o scoperto la legge di gravitazione universale.
L’uomo ha imparato e insegnato ad attraversare il mare e le onde che si spalancano intorno schiumose, a lavorare la terra, a catturare, piegare, addomesticare, distruggere, divorare altre creature; a violare e a vincere le leggi della natura che scopriva, ad arare la terra e la vita stessa, a cambiare di continuo il volto della natura e delle sue creature mostruose come quelle delle origini di cui canta Lucrezio Ha insegnato a se stesso la parola e il pensiero più rapido del vento, ha costruito e distrutto leggi e città, si è spinto – mai come oggi – più avanti del futuro. Ha sconvolto e sta sconvolgendo leggi, valori e sentimenti che la comunità umana vive come duraturi, stabili leggi del mondo, della mente e del cuore. L’uomo è dissezione; altera, annienta i fondamenti stessi della stabilità e della continuità del suo essere.
Ma quando, dove incomincia la storia di quello che chiamiamo l’uomo? Quando, dove inizia l’uomo di cui predichiamo diritti e doveri? Quando comincia il male che “l’uomo” compie o subisce, quando possiamo deplorare come umani i suoi crudeli pregiudizi o ammirare come umani la sua capacità di scoprire le leggi della fisica e dell’etica, che lo trascendono? Se Darwin ha ragione e l’uomo è la storia della sua evoluzione, sin dove possiamo andare indietro a parlare dell’uomo, dei suoi diritti, di una sua dignità rispettata o offesa, di noi? Siamo credo d’accordo che gli indiani Fuegini appesi in gabbia all’Expo internazionale di Parigi nel 1889, su suggerimento di Darwin, quasi fossero un’altra specie rispetto a noi, fossero vittima di un pregiudizio barbarico.
Ma da quando si può parlare di “uomo”, nella nebbia del passato? Possiamo considerare nostro nonno Luca, Last Universal Common Ancestor, il microrganismo ancestrale che ci apparenterebbe a funghi e amebe? I discorsi sull’uomo possono, devono includere gli ominidi?
L’ “Oltre-uomo” di Nietzsche, nuovo stadio, nuova forma e nuova realtà dell’Io, è un uomo o se lo è lasciato alla spalle come un animale preistorico? Quisquilie, rispetto alle atroci ingiustizie e violenze imposte per millenni e millenni e ancor oggi a moltitudini di dannati della terra, cui – ancor oggi – si stenta a riconoscere la natura e la dignità di uomini, di nostri fratelli. Talora sembra che la nostra epoca voglia distruggere la carne che è stata necessaria al Verbo.
Nella Silicon Valley si sta lavorando, pare, per abolire la morte. Per quale vita? Si è chiesto, in una poesia, Juan Octavio Prenz. Quando si può – e si deve – dire “Ecce homo” ?
Claudio Magris